 Nonostante l’abitudine non saprei proprio come definire il modo di guidare in India. Il primo sentore di diversità l’ho colto al mio arrivo, durante il tragitto dall’aeroporto alla missione che mi avrebbe ospitato. Era mezzanotte passata a Bangalore mentre percorrendo in taxi la strada che porta al centro della città ero immerso un turbinio di attività, rumori di auto, clacson e fumi che a poco a poco mi hanno destato dal torpore del viaggio e dell’ora tarda. Ho vissuto come un sogno quei primi momenti convulsi che però si sono ripresentati quotidianamente ogni volta che mi avventuravo per strada.
Nonostante l’abitudine non saprei proprio come definire il modo di guidare in India. Il primo sentore di diversità l’ho colto al mio arrivo, durante il tragitto dall’aeroporto alla missione che mi avrebbe ospitato. Era mezzanotte passata a Bangalore mentre percorrendo in taxi la strada che porta al centro della città ero immerso un turbinio di attività, rumori di auto, clacson e fumi che a poco a poco mi hanno destato dal torpore del viaggio e dell’ora tarda. Ho vissuto come un sogno quei primi momenti convulsi che però si sono ripresentati quotidianamente ogni volta che mi avventuravo per strada.
Ricordo con stupore e apprensione la suora di aspetto e modi gentili, una figura minuta e in sintonia con la propria micro macchina quando mi ha accompagnato in giro per la città. Vista la guida opposta alla quale siamo abituati, nei primi momenti mi sentivo a disagio occupando quello che pensavo fosse il posto di guida, senza trovare il volante e, sopratutto, il conforto del pedale del freno.
Lei, con gesto sicuro, sale alla destra dell’auto e al posto dei gesti cui siamo abituati, come allacciarci la cintura di sicurezza e controllare l’orientamento dello specchietto retrovisore, la gentile signora afferra un rosario e innesca una sequenza di parole che non intendo ma che immagino siano parte della liturgia del momento. Fatto ciò, ingrana la marcia e parte ad una velocità da Gran Premio uscendo dal cortile dove aveva parcheggiato, incurante dei numerosi passanti che in quel momento transitavano sul marciapiedi davanti a lei.
Questi, come per magia si dissolvono al suo arrivo, quasi allertati da un sesto senso che solo in quei luoghi mistici è presente. Io mi sveglio dalla sorpresa e mi ritrovo a dare dei pestoni col piede destro dove il mio istinto colloca il pedale del freno; poi, rendendomi conto del mio comportamento ridicolo, cerco di darmi un contegno mentre la mia autista affronta la stradina con una serenità e una luce negli occhi che in occidente sarebbe sospetta.
Dopo alcuni tentativi di omicidio, piume di polli starnazzanti e una mucca indolente un po’ seccata da quella frenesia, arriviamo sulla strada principale dove la nostra corsa finisce impantanata in un mucchio di ferraglia fumante e rumorosa che i locali chiamano traffico. Non si capisce bene il senso di marcia perché ciascuno ha la tendenza ad occupare tutti gli spazi vuoti compresa la corsia opposta, incurante dei mezzi che sopraggiungono. In questo ambiente sereno ed educato talvolta capita che qualcuno distolga la mano dal clacson, forse per riposare le dita o forse per indicare a gesti dove vorrebbe mandare il vicino di corsia.
In un ambiente, la strada, in cui ciascuno avanza senza regole apparenti, non c’è discriminazione, si offende e si viene offesi costantemente senza che ciò perturbi gli automobilisti. Le espressioni che vedo sulle facce dei passeggeri dei moto-risciò sono tutte rilassate ed indifferenti alla bolgia, segno della normalità di quel procedere.
Visto questo, penso che il rosario snocciolato dalla mia autista sia stato una sorta di richiesta di perdono preventiva per quello che avrebbe fatto con la sua guida folle e capisco pure gli altarini che i locali pongono sul cruscotto dei propri mezzi; le varie divinità orientali o santità occidentali devono avere un bel da fare per salvaguardare la salute lungo quelle strade.
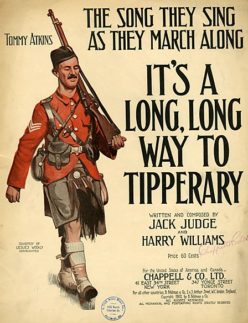
 Mi raccontava Lindbergh che il decollo ha sempre rappresentato per lui un motivo di ansia che svaniva solo quando il carrello, con un ultimo sussulto, lasciava la terra per non più ricadervi. Ecco, diceva: il tempo che intercorre tra quell’ultimo tonfo e il momento in cui capisci che non ve ne sarà un altro è il più lungo di cui un uomo possa avere esperienza. Tranne forse quello che segue quando la moglie ti dice: “Dobbiamo parlare”.
Mi raccontava Lindbergh che il decollo ha sempre rappresentato per lui un motivo di ansia che svaniva solo quando il carrello, con un ultimo sussulto, lasciava la terra per non più ricadervi. Ecco, diceva: il tempo che intercorre tra quell’ultimo tonfo e il momento in cui capisci che non ve ne sarà un altro è il più lungo di cui un uomo possa avere esperienza. Tranne forse quello che segue quando la moglie ti dice: “Dobbiamo parlare”. Cherie lo incontrò al termine del suo spettacolo, un tipo interessante, spavaldo, sicuramente rude ma con un sorriso che fa sparire ogni cosa nella stanza. Quando le si avvicinò, lei gli chiese: “Ehi, come ti chiami?” (non si capisce perché la domanda dovesse essere preceduta da “ehi” ma così fu e concediamo a lei, bella come il sole al tramonto, un momento di imbarazzo lessicale).
Cherie lo incontrò al termine del suo spettacolo, un tipo interessante, spavaldo, sicuramente rude ma con un sorriso che fa sparire ogni cosa nella stanza. Quando le si avvicinò, lei gli chiese: “Ehi, come ti chiami?” (non si capisce perché la domanda dovesse essere preceduta da “ehi” ma così fu e concediamo a lei, bella come il sole al tramonto, un momento di imbarazzo lessicale).