 Giornata asciutta e ventilata, l’ideale per impastare. Soprattutto ho il tempo per farlo; non che impegni molto, ma quando si gioca con la pasta è meglio non avere distrazioni come telefoni suonanti o amici alla porta. Per impastare occorre la musica classica. Non chiedetemi perché ma l’esperienza mi dice che la pasta viene meglio con Mozart che con Zucchero.
Giornata asciutta e ventilata, l’ideale per impastare. Soprattutto ho il tempo per farlo; non che impegni molto, ma quando si gioca con la pasta è meglio non avere distrazioni come telefoni suonanti o amici alla porta. Per impastare occorre la musica classica. Non chiedetemi perché ma l’esperienza mi dice che la pasta viene meglio con Mozart che con Zucchero.
Ho già tirato fuori dal frigorifero le 4 uova perché arrivino alla stessa temperatura della farina e preparo tutto l’armamentario per l’avvenimento: madia di legno, macchina per tirare la sfoglia, terrina per impastare, forchetta, bilancia, sale e…musica !
Quattro etti di farina per quattro uova (mi sembra il titolo di un vecchio film): verso la farina nella terrina e lascio un avvallamento nel centro per dare il benvenuto alle uova; le salo leggermente (mezzo cucchiaino) e con la forchetta inizio a sbattere le uova includendo a poco a poco la farina. In questa fase occorre affinare l’esperienza perché quando si pensa che l’impasto sia pronto per essere lavorato con le mani, si ha la sorpresa di impantanarsi senza speranza, alzando gli occhi alla disperata ricerca di qualcuno che ci liberi dal Blob appena creato.
Se la pazienza ci sorregge ancora per qualche momento, possiamo saggiare la consistenza dell’impasto usando una sola mano, in modo che se questo fosse troppo umido, con l’altra possiamo aggiungere farina in modo da riequilibrarlo. Alla fine, si può abbandonare la terrina per proseguire sulla madia opportunamente cosparsa di un velo di farina.
Ora inizia la fase in cui si coccola la pasta direttamente sulla madia, premendo con i polsi e, ottenuto un piccolo rotolo, lo si arrotola su se stesso cambiando il verso di lavorazione e ripetendo nuovamente l’operazione. Il calore delle mani aiuta gli ingredienti ad amalgamarsi e questo tocco umano, una macchina per impastare non lo darà mai. Si aggiunge farina poco per volta finché l’impasto tende ad attaccarsi alla madia o alle mani e al termine lo si lascia riposare sotto una stoffa di lino. Penso che questa cosa del riposo sia stata inventata apposta dai cuochi per fare una pausa dal lavoro, ma forse è solo una malignità.
Con un coltello taglio un pezzo di impasto che, dopo aver infarinato infilo tra i rulli della macchina, avendo selezionato l’ampiezza maggiore. Lo passo più volte e vedo che ora sta diventando un abbozzo di sfoglia; dopo un primo passaggio, infarino leggermente, la piego in due e ripeto l’operazione per due o tre volte. Ora diminuisco la distanza dei rulli e passo la sfoglia senza più ripiegarla, infarinandola quando occorre e facendo attenzione che scorra in modo lineare ottenendo una striscia di pasta più uniforme possibile.
Ripeto questa operazione fino al penultimo selettore di regolazione, poiché l’ultimo è destinato solo alle tagliatelle. Taglio le sfoglie della lunghezza desiderata e le passo attraverso lo strumento per il taglio della pasta. Quella che esce è una fragrante cascata di taglierini dalla consistenza ruvida al punto giusto e profumati di uovo, docili al tocco ma dotati di anima nobile.
Li dispongo sui vassoi già infarinati con gesti delicati come se si adagiassero dei neonati nel loro lettino, in modo che la pasta si asciughi in attesa della cottura. Ormai il lavoro è concluso e non rimane altro da fare che aspettare il momento in cui la pasta incontrerà il sugo. Ma questa è un’altra storia.
 Mi raccontava Lindbergh che il decollo ha sempre rappresentato per lui un motivo di ansia che svaniva solo quando il carrello, con un ultimo sussulto, lasciava la terra per non più ricadervi. Ecco, diceva: il tempo che intercorre tra quell’ultimo tonfo e il momento in cui capisci che non ve ne sarà un altro è il più lungo di cui un uomo possa avere esperienza. Tranne forse quello che segue quando la moglie ti dice: “Dobbiamo parlare”.
Mi raccontava Lindbergh che il decollo ha sempre rappresentato per lui un motivo di ansia che svaniva solo quando il carrello, con un ultimo sussulto, lasciava la terra per non più ricadervi. Ecco, diceva: il tempo che intercorre tra quell’ultimo tonfo e il momento in cui capisci che non ve ne sarà un altro è il più lungo di cui un uomo possa avere esperienza. Tranne forse quello che segue quando la moglie ti dice: “Dobbiamo parlare”.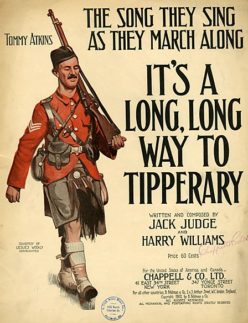
 Cherie lo incontrò al termine del suo spettacolo, un tipo interessante, spavaldo, sicuramente rude ma con un sorriso che fa sparire ogni cosa nella stanza. Quando le si avvicinò, lei gli chiese: “Ehi, come ti chiami?” (non si capisce perché la domanda dovesse essere preceduta da “ehi” ma così fu e concediamo a lei, bella come il sole al tramonto, un momento di imbarazzo lessicale).
Cherie lo incontrò al termine del suo spettacolo, un tipo interessante, spavaldo, sicuramente rude ma con un sorriso che fa sparire ogni cosa nella stanza. Quando le si avvicinò, lei gli chiese: “Ehi, come ti chiami?” (non si capisce perché la domanda dovesse essere preceduta da “ehi” ma così fu e concediamo a lei, bella come il sole al tramonto, un momento di imbarazzo lessicale). Giornata asciutta e ventilata, l’ideale per impastare. Soprattutto ho il tempo per farlo; non che impegni molto, ma quando si gioca con la pasta è meglio non avere distrazioni come telefoni suonanti o amici alla porta. Per impastare occorre la musica classica. Non chiedetemi perché ma l’esperienza mi dice che la pasta viene meglio con Mozart che con Zucchero.
Giornata asciutta e ventilata, l’ideale per impastare. Soprattutto ho il tempo per farlo; non che impegni molto, ma quando si gioca con la pasta è meglio non avere distrazioni come telefoni suonanti o amici alla porta. Per impastare occorre la musica classica. Non chiedetemi perché ma l’esperienza mi dice che la pasta viene meglio con Mozart che con Zucchero.